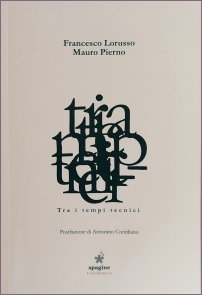 Francesco Lorusso Mauro Pierno, Tra i tempi tecnici – Ed. Spagine, Associazione Culturale Fondo Verri, Lecce, 2021
Francesco Lorusso Mauro Pierno, Tra i tempi tecnici – Ed. Spagine, Associazione Culturale Fondo Verri, Lecce, 2021

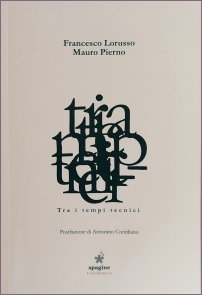 Francesco Lorusso Mauro Pierno, Tra i tempi tecnici – Ed. Spagine, Associazione Culturale Fondo Verri, Lecce, 2021
Francesco Lorusso Mauro Pierno, Tra i tempi tecnici – Ed. Spagine, Associazione Culturale Fondo Verri, Lecce, 2021

John Taylor – Transizioni – Ed. Lyriks, 2021
John Taylor ci presenta ancora un libro notevole (nella traduzione di Marco Morello, con brevi note di Tommaso Di Dio e Franca Mancinelli, e illustrazioni di Alekos Fassianos), con il quale continua il suo personale percorso di decantazione di una scrittura già raffinata ed essenziale, come quella che era stato possibile leggere nel suo Oblò / Portholes (v. QUI), raccolta che possiamo considerare in qualche misura affine a questa ultima. Libri legati al mare, all’orizzonte, ad una visione quasi atomica delle cose, allo scorrere del tempo e in egual misura al suo cristallizzarsi in momenti che non sono tanto occasionali epifanie quanto l’umano avvertire nel mondo, come nella parusia platonica, la presenza di qualcosa di intensamente spirituale che evolve. Come scrive Franca Mancinelli “il suo sguardo [di Taylor] è richiamato dall’istante in cui le cose non sono più se stesse e insieme non sono ancora altro: è l’incanto del trasmutare, delle molteplici transizioni attraverso cui il giorno diviene notte, il buio si fa luce e la vita si avvera nel suo miracolo: «l’acqua […] sale / dalla scura terra». Ciò che avviene in questa sospensione può appena sfiorare la parola per poi subito rientrare nel non dicibile. Per questo i versi sono spesso brevi, come se Taylor tentasse di sillabare una lingua sconosciuta che coincide con il ritmo che avvicina e allontana le onde dalla riva”. Come ho già scritto John è uno scrittore europeo a pieno titolo, per stile, per ascendenti letterari, per cultura, e sarebbe possibile trovare nei suoi versi echi dei moltissimi poeti che ha tradotto e fatto conoscere in America, non solo francesi ma anche italiani come Alfredo de Palchi e Lorenzo Calogero. Qui ci trovo certamente Valéry, citato in esergo, ma anche un Mallarmé che va verso la luce, che abbia trovato sì una sua chiarità post-ermetica ma che continui a captare (ed è lo statuto del poeta) i segreti legami tra le cose, con quella visione quasi atomica a cui accennavo all’inizio. E tuttavia, come afferma Tommaso Di Dio, “non vi è qui nulla di misterioso che non sia evidente, nulla di occulto che non sia sotto gli occhi di tutti. L’estrema concentrazione formale di questa poesia porta alla rivelazione mediante contrazioni rapidissime, fulminei abbagli, iridescenze; la vertigine dei tempi e la tautologia dei deittici si fa pura materia espressiva: «questo mare quel mare / è fu / diventerà». Non posso che essere d’accordo, il poeta in realtà non inventa nulla, semmai immagina e riscrive la realtà che c’è, la interpreta facendo della poesia uno strumento ermeneutico. E la forma breve, per quanto poi allungata nelle due sezioni che sono quasi poemetti, serve a depurare ulteriormente, verso per verso, il lirismo che si accompagnava alle sue opere precedenti, nella direzione di una sublimazione che da una parte è quasi orientale, in testi dove non è infrequente trovare porzioni che potrebbero essere tanka (”lo scintillio / nell’aria / sull’acqua / così uniforme / così avvolto dalla luce nebbiosa // il mare qualcos’altro / in quest’ora senza vento…”), dall’altra ci rimanda a Quasimodo, Ungaretti, Saba. Su tutto aleggia il movimento incessante dell’acqua, delle onde, degli elementi, della memoria, come una vitale vibrazione cosmica. (g. cerrai) Continua a leggere

Ripubblico qui nel loro insieme alcune delle prime traduzioni che ho fatto per il vecchio blog, tra il 2005 e il 2008, che riguardano Jane Kenyon, una poetessa americana in pratica sconosciuta in Italia. All’epoca avevo contattato l’editore statunitense, ottenendo l’autorizzazione a pubblicare. Sarebbe interessante lavorare ad una antologia almeno delle quattro raccolte pubblicate in vita, oltre alle opere postume. Si accettano proposte editoriali. (g.c.)
Domenica, 27 novembre 2005
Jane Kenyon (1947-1995) e’ nata ad Ann Arbor nel Michigan e ha frequentato l’università‘ del Michigan dove ha conseguito il Master of Arts nel 1972. Nello stesso anno ha sposato il poeta Donald Hall, suo insegnante all’università‘, e insieme sono andati a vivere a Wilmont nel New Hampshire, terra d’origine del marito. Sebbene la Kenyon abbia felicemente descritto la sua vita nel New Hampshire rurale, come nel suo primo libro Let Evening Come pubblicato nel 1990, ha sofferto per gran parte del suo matrimonio di una grave depressione e le sue ultime poesie, come quelle qui pubblicate, descrivono la sua lotta contro di essa e contro la leucemia che la porterà alla morte nel 1995.
Di Jane Kenyon colpisce l’aderenza alle cose e al senso che ne deriva, la profonda umanità anche di fronte alle avversità che la vita presenta. John H. Timmerman, autore di una sua biografia critica, afferma: “La spiritualità di Jane non era mai un mezzo per sfuggire all’esistenza. Al contrario, le consentiva di abbracciare la realtà con tutta la sua risoluta bellezza e la sua invadente sofferenza”. Cosa lei pensasse del poetare è chiaramente espresso nella risposta che la Kenyon dette ad una domanda dello stesso Timmerman: “Il lavoro del poeta è di dire la verità e nient’altro che la verità, in un modo così meraviglioso che la gente non possa vivere senza di essa; di mettere in parole quelle emozioni che noi tutti abbiamo che sono così profonde, così importanti e tuttavia così difficili da chiamare per nome. Il lavoro del poeta è scoprire un nome per tutto: essere un impavido ricercatore del nome delle cose; essere un difensore della bellezza del linguaggio, delle sottigliezze del linguaggio. Penso che sia una materia davvero seria, l’arte; non è solo ornamento. L’altro mestiere del poeta è consolare di fronte all’inevitabile disgregazione del decadimento e della morte, tutte le dolorose cose che dobbiamo affrontare come esseri umani. Noi abbiamo la consolazione della bellezza, di un’anima che si espande verso un’altra e dice “Anch’io sono stata là ”. Continua a leggere
 Valeria Rossella – Quello che vedo – Interlinea Edizioni 2021
Valeria Rossella – Quello che vedo – Interlinea Edizioni 2021 Come giuria della sezione C (poesie inedite) di Bologna in Lettere 2021 abbiamo anche il compito di stendere le motivazioni dei premi (o delle segnalazioni, come in questo caso). Pubblico anche qui, insieme ai testi, quelle di cui sono autore. – 2 –
Come giuria della sezione C (poesie inedite) di Bologna in Lettere 2021 abbiamo anche il compito di stendere le motivazioni dei premi (o delle segnalazioni, come in questo caso). Pubblico anche qui, insieme ai testi, quelle di cui sono autore. – 2 –
Anita Piscazzi – Lo scompenso delle immagini
Piscazzi sceglie l’elegia, in questi tre testi, la malinconia, il dolore di un nostos non necessariamente chiaro e definito, l’andamento un po’ stupefatto e un po’ errabondo di chi scopre un luogo della poesia in quel “niente in tasca” di cui parla nel primo brano, sapendo però che corrisponde non ad un nihil esistenziale, ad un vuoto, ma ad una assenza, un dolore, un’inquietudine indefinita, forse senza oggetti bersaglio denotati, ma non per questo meno “presente”, meno angustiante. L’indefinito, il generico, l’astratto fanno logicamente sponda al simbolico, ad una voce che sembra echeggiare in stanze ombreggiate, il tono è di primo acchito quasi pitico e non solo per un uso del perfetto che rimanda ad un mito, ad una storia o mistero personale o per un uso del verso libero a tratti predittivo. Ma anche per un lanciare segnali a chi legge, come a volerlo informare di un invisibile tutt’altro che privato, come ad esempio la convinzione che “il petto degli altri è un lupo”, che da certe catabasi della memoria si torna, ecco, con niente in tasca, a parte un po’ di rimpianti. Certo è comprensibile che in questa indagine di zone d’ombra, di angoli del sé in rapporto alla propria esperienza l’immagine sia appunto “scompensata”, smarginata – dice Piscazzi – come una riva senz’acqua, sia cioè un limitare privo di ciò che lo rende tale, ovvero privo di un colloquio tra elementi, e perciò stesso sia perturbante o crei uno “scontento inquieto”. La poesia sta allora (per citare l’autrice) nel segretamente abitare il proprio senso cieco e oscuro, ancor di più nel testimoniare (fare testamento) del passaggio di un Angelo di luce, sia essa la semplice luce nuova che l’inverno promette o quella sorgente “sulle ossa sparse nei mari / sulla morte della viola di marzo”. Un angelo, forse necessario, ci auguriamo, come quello di cui scriveva Wallace Stevens. (g. cerrai) Continua a leggere
 Come giuria della sezione C (poesie inedite) di Bologna in Lettere 2021 abbiamo anche il compito di stendere le motivazioni dei premi (o delle segnalazioni, come in questo caso). Pubblico anche qui, insieme ai testi, quelle di cui sono autore. – 1 –
Come giuria della sezione C (poesie inedite) di Bologna in Lettere 2021 abbiamo anche il compito di stendere le motivazioni dei premi (o delle segnalazioni, come in questo caso). Pubblico anche qui, insieme ai testi, quelle di cui sono autore. – 1 –
Erika De Felice – Lungomare, Zara
Quella di Erika De Felice è poesia colloquiale, in conversazione con un tu di riferimento (“hai mai pensato…”, “per ricomporsi sai…”) che è specchio ed assenza, o forse è – almeno poeticamente – un alter ego con cui rapportarsi. Il luogo, l’ora (22.45 dei giovedì dispersi) sono puri palcoscenici, come quando si rimugina guardando l’orizzonte seduti su un molo, la presenza fisica è marginale rispetto al lavorìo del pensiero, la verbalizzazione di questo pensiero è connotata da una frammentazione di quello che poeticamente si riesce e si vuole ricordare, registrare a futura lettura, che poi è in parte il meccanismo della memoria (tutta questa poesia è in fondo memoriale e perciò elegiaca), e quindi secondo una procedura (non tanto retorica o testuale, quanto magari psicologica) metonimica (una parte frazionaria per il tutto, ad es.: “Le tue spalle / e il mio peso del mondo / solo questo ricordo / questo solo di te”), di cui anche la scrittura, la forma sono specchio. Un procedimento che rende questa poesia decisamente affettiva e perciò stesso immediatamente – diciamo – agréable, nel suo poggiarsi in definitiva su un ventaglio di sentimenti di privazione e di solitudine che conosciamo, che sono umani e quindi a noi (terenziani lettori) non alieni. Ma il sentimento di inquieta aspettativa di qualcosa non destinato al ritorno, al recupero, al nuovo abbraccio, quel sentimento è definitivo, “come una notte che non risorge”, ci dice l’autrice. Questa mancanza di un’alba (o qualsiasi speranza) è agnostica e perciò conchiusa in sé, qualsiasi esperienza in fondo, per quanto ripetibile in poesia, avviene per consumazione della stessa come in un giorno anch’esso ripetibile, “quest’oggi [che] non è passato”, qualcosa a cui forse ci si abitua (“nulla mi ripugna di te / nemmeno la morte che scorre sottile / nemmeno questo pallido vento”) ma a cui in fondo non si vuole credere (“e dimmi, alla fine / è poi questa la fede?”). La poesia dà voce, come può, a questo dibattersi come all’interno di una Skinner box, una gabbia da esperimento, una condizione che ha un che di destinale, di ontologico, forse – come l’angoscia – non del tutto sensato quanto irriducibile. “Questa vita – corpo confuso / ci contiene per sbaglio”. Il resto del mondo appare precluso. (g. cerrai) Continua a leggere
 Pubblico raramente, su questo blog, qualcosa di mio. In questo caso è l’inizio di qualcosa. Inizio che è avvenuto anni fa. Qualcosa di cui non è facile dire con esattezza di che cosa si tratti. Prima c’è (c’è stato) il testo, poi questo video che, tutto sommato, è ancora testo, sebbene sia corredato da immagini e voce. Nihil è una persona ma non un personaggio. È semmai un esemplare di un lenta ma inesorabile mutazione antropologica. E il testo è il testo, nel senso che solo le parole hanno il diritto di rinfacciare qualcosa a qualcuno. (g.c.)
Pubblico raramente, su questo blog, qualcosa di mio. In questo caso è l’inizio di qualcosa. Inizio che è avvenuto anni fa. Qualcosa di cui non è facile dire con esattezza di che cosa si tratti. Prima c’è (c’è stato) il testo, poi questo video che, tutto sommato, è ancora testo, sebbene sia corredato da immagini e voce. Nihil è una persona ma non un personaggio. È semmai un esemplare di un lenta ma inesorabile mutazione antropologica. E il testo è il testo, nel senso che solo le parole hanno il diritto di rinfacciare qualcosa a qualcuno. (g.c.)
 Riccardo Delfino – Il sorriso adolescente dei morti – RPLibri 2021
Riccardo Delfino – Il sorriso adolescente dei morti – RPLibri 2021 L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di Augusto Blotto ([dia*foria / dreamBOOK, ISBN 9788899830519, pagg. 260, con interventi di Giacomo Cerrai, Philippe Di Meo, Chiara Serani, Stefano Agosti) tenta con la speranza di qualche successo non solo di ampliare la conoscenza di questo grande vecchio (Torino, 1933) della poesia italiana, ma anche di riaccendere l’attenzione su di un autore forse appartato ma certo non più adeguatamente analizzato, con rare eccezioni, dopo la giornata di studi a lui dedicata a Torino il 27 novembre 2009 (ora in Il clamoroso non incominciar neppure – Atti della giornata di studio in onore di Augusto Blotto (Ed. dell’Orso, 2010, con quattordici saggi di vari importanti autori).
L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di Augusto Blotto ([dia*foria / dreamBOOK, ISBN 9788899830519, pagg. 260, con interventi di Giacomo Cerrai, Philippe Di Meo, Chiara Serani, Stefano Agosti) tenta con la speranza di qualche successo non solo di ampliare la conoscenza di questo grande vecchio (Torino, 1933) della poesia italiana, ma anche di riaccendere l’attenzione su di un autore forse appartato ma certo non più adeguatamente analizzato, con rare eccezioni, dopo la giornata di studi a lui dedicata a Torino il 27 novembre 2009 (ora in Il clamoroso non incominciar neppure – Atti della giornata di studio in onore di Augusto Blotto (Ed. dell’Orso, 2010, con quattordici saggi di vari importanti autori).
Incominciamo col dire che questo volume non è una delle opere di Augusto Blotto, per il quale non vige affatto né il concetto di compiutezza “finita” né quello di un determinarsi conseguente e successivo del lavoro poetico né, forse, nemmeno quello ancora di tempo lineare, sebbene ogni suo libro abbia poi una sua precisa identità, una “aura che vi circola” come dice lui. È semmai una delle “emergenze”, degli affioramenti dell’inesausto lavorio blottiano. Blotto infatti è autore di un lavoro sterminato (circa ventisei opere a stampa e materiale per ipotetici almeno altri ventinove volumi), e anche questo libro è una sorta di carotaggio, una ricognizione campionaria per “estrazioni dai giacimenti” di quella che possiamo chiamare d’ora in avanti l’Opera, ovvero “l’enfin”, attualmente composto da oltre 2700 cartelle. Blotto, come scrisse uno dei suoi estimatori Giovanni Tesio, è un poeta “di sfide e dismisure”, un ricercatore indefesso che scava nel corpo immenso del linguaggio e della realtà che esso rappresenta, ne rivoluziona la sintassi, rivede senza patemi gli schemi metaforici, gli accostamenti di senso, le immagini che ne derivano, insomma un osservatore acribico del mondo che egli, grande camminatore, percorre come uno specialissimo flâneur ricevendone stimoli fluviali che l’autore organizza ed ha organizzato nel corso del suo lavoro in quello che Daniele Poletti nell’introduzione definisce un mastodontico iperoggetto letterario, uno spazio vasto che ricomprende tutti i paesaggi in cui Blotto ha fatto irruzione ridefinendoli in una nuova matrice. Ed è il linguaggio una delle maggiori peculiarità della sua poesia, una lingua non meramente strumentale né mimetica del caos del mondo, della sua incomprensibilità, ma intesa – tra le altre cose – come manifestazione del tempo (letterario ed esistenziale) quale “visione sincronica ed onnivora della realtà”, ove “il tempo è momento, o un luogo quasi topologico in cui precipitano le cose, gli oggetti, gli “accidenti” – nonché il linguaggio che li determina – e che ha una durata pari a quella del testo che li contiene, ma che non ha altra rappresentazione per così dire “lineare” o analogica, non fluisce, non ha nemmeno la figurazione di un prima e di un dopo attraverso la sintassi, la cui mobilità è segnale semmai che la realtà “avvenuta” è soggetta a una continua (finché il testo lo consente) revisione testimoniale”[1]. Ma “il linguaggio sembra avere per Blotto un peccato originale, una tabe, variamente connotata, in primis dalla rigidità del codice, con il quale tuttavia, in quanto materia, dobbiamo avere a che fare (non dimenticando che il linguaggio nella sua essenza è sempre “narrativo”, sequenziale, ordinatorio, e vive nel tempo che il testo si è dato, come abbiamo detto). E poi connotata da un comfort associativo, con cui la mente giunge a conclusioni “economiche”, in qualche caso anticipatorie, “usabili” e quindi in varia misura scontate”[2]. È l’ “ordine costituito del linguaggio” che viene da Blotto rivoluzionato, anche spessissimo sotto il profilo sintattico, cose che non impediscono però a Blotto di attingere vette anche liriche, anche umoristiche e sempre di altissimo valore descrittivo e iconico. Perché “l’atteggiamento di Blotto non è puramente contestatorio: la distruzione (la messa in crisi) dei meccanismi è in realtà la ricostruzione delle loro macerie sotto altra forma, con altri mezzi, è la proposta (peraltro un po’ imperiosa) di non lasciarsi intimorire dal sublime, nel senso di gettare uno sguardo su di una vastità impressionante, che riguarda, come un Caspar David Friedrich delle parole, quella delle possibilità del linguaggio”[3]. Blotto è poeta ricchissimo, non solo della cultura che dimostra e trasfonde nei suoi versi, ma anche di una infinità di dati informativi, sensoriali, eidetici, linguistici, oggettuali e ideativi che fornisce al lettore. Il quale, se può essere soggetto ad un “sentimento di instabilità, di non comfort (concetto tutt’altro che peregrino, basti pensare al barthesiano “piacere del testo”)”, è perché viene “condizionato” anche cognitivamente. “Condizionamento” (usiamo ancora le virgolette) che, nel suo caso, “non riguarda soltanto l’espressione di una sua realtà, ma anche come questa realtà debba essere riformulata, tramite il linguaggio, nel pensiero, anche di chi legge”[4]. Non è una semplice seduzione, è la più alta corresponsabilità del lettore. Una esperienza che possiamo definire assoluta. (g.cerrai) Continua a leggere
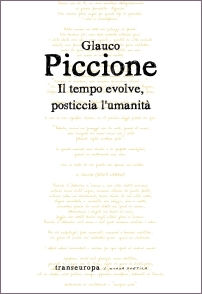 Glauco Piccione – Il tempo evolve, posticcia l’umanità – Transeuropa ed., 2021
Glauco Piccione – Il tempo evolve, posticcia l’umanità – Transeuropa ed., 2021Non ci si entra subito, in questo libro, pur con i buoni auspici dell’autore, il quale in effetti spande generosamente una sua idea di poesia, ma soprattutto una sua idea di che cosa la poesia dovrebbe parlare. In breve: libro di invettive e riflessioni, con una cifra stilistica a volte esorbitante, come vedremo, in cui però non si entra subito perché la scrittura di Piccione non è e non vuole essere immediatamente decifrabile, aspirando ad una certa “oscurità” creativa del linguaggio, ad una certa sperimentazione verbale che però tende a “complicare”, sempre con volontà di sperimentare, una più o meno acquisita tradizione, riconosciuta e dichiarata dall’autore come serbatoio. “Un’opera in versi che trae le proprie influenze dalla poesia italiana degli anni Settanta e da un particolare vissuto personale, che tenta di rielaborare le esperienze della cultura beat, della cultura psichedelica e della cultura hobo” mi dice l’autore in un messaggio privato. Quindi, forse, un antico che tenta di ritornare nuovo, e qualcosa di insolito per un autore nato nel 1990. Influenze di temi, o renovatio di essi, gestione della “rabbia” giovanile o meno, contenuto che quasi inevitabilmente genera o richiama la forma e insieme ne è generato, una certa distopia (nel senso di una qualche discrasia tra l’attuale e il linguaggio che lo rappresenta, che lo pone per così dire fuori dal tempo)? No, non è tutto qui, naturalmente, seppure – comun denominatore di tutto il predetto – una scrittura generalmente magmatica, effusiva, richiami una notevole passione – abbastanza inusuale ormai in giovani di questa generazione – che cerca nella scrittura stessa un espressionismo d’impatto, un peso specifico da consegnare al lettore. Passione che a tratti sembra voluta, autoimposta, in qualche modo autodescritta, proprio mentre l’autore tenta di oggettivarla, chiamandosene antiliricamente fuori. E sì, anche se Piccione non me lo avesse scritto, c’è in molti di questi testi, anche linguisticamente, una specie di dito puntato verso una realtà che possiamo far finta di guardare criticamente da fuori ma di cui invece siamo – certo drammaticamente – intrisi. E questo è un fatto linguistico, come dicevo, molto più di quanto possa essere, oggi come oggi, politico, un recupero appunto di modalità espressive che è vero che trovavano la loro motivazione in un bisogno diciamo antagonista, ma che non sarebbe male recuperare applicandole però ad una realtà molto più complessa e “liquida” di quanto fosse allora. Se c’è qui qualcosa di post moderno in questo tipo di poesia (di Piccione e di altri) è un disincanto non aggressivo, una consapevolezza della fine di qualsiasi delle “grandi narrazioni” di cui parlava Lyotard (sostituite in poesia da due concetti fissi come “presente” e “frammentarietà”). Senza contare, qui come altrove nel panorama – ed è quasi ovvio -, l’espulsione dell’io/poeta, rarissimo in questo libro, quasi un mero elemento del paesaggio, un deittico che mi pare, quando c’è, corrisponda ad una autochiamata in correo, più che a una testimonianza. Non che la presenza dell’autore difetti, tutt’altro, diciamo che la presenza, qui, è piuttosto peso stilistico, scelta programmatica di tonalità e, come s’è visto, di numi tutelari. Queste scarne considerazioni però non ci sviino, noi o il lettore, dall’affermazione iniziale, l’essere cioè il libro interessante, di esserlo, in un certo senso, comunque, al di là cioè di certa (faccio un esempio) ansia che a volte trapela, di mettere in testo tutti gli ingredienti a disposizione. Ne consegue, a tratti, un certo barocchismo della parola (specie nelle poesie diciamo più “impegnate”, cioè con più “foga”): un surplus di significanti che da una parte conducono all’assemblaggio, all’accostamento enunciativo di termini in apparenza alieni (1) che (ipotesi) potrebbero aspirare lodevolmente alla creazione di metafore/metonimie/similitudini innovative, oppure (ipotesi) tentare sperimentalmente di fare un uso iconico/mimetico del linguaggio per designare il caos, il complesso, l’indicibile per quanto sia – per ossimoro – poeticamente descrivibile. Gli elementi ci sono quasi tutti, enumerazione, accumulazione, elenchi, innesti linguistici, associazioni, visione del mondo oggettuale onnivora, polimorfica, sinestetica, sguardo inquieto e quindi pluriprospettico e quindi non poche volte tagli del testo per frames, inquadrature, salti di luogo e di campo visivo, insomma cinematografia. Tutte cose non nuovissime, ma va bene così, perché al di là delle sue dichiarazioni Piccione una renovatio l’ha fatta, è riuscito a costruirsi un suo stile che certo ha bisogno a mio avviso di qualche aggiustamento ma che riesce a dominare alla fine la materia poetica di cui dispone, i temi che gli stanno a cuore. In altri termini è riuscito, direi rubando parole all’autore, ad esercitare spesso “la sorveglianza nel progettar confuso / del lasciare andare”. Del resto come si fa, trattando ad esempio de “L’acrobatismo incantevole del disastro” (come titola la prima sezione del libro), cioè quella specie di ballo sul Titanic che è l’attuale situazione del mondo, a non costruire testi che rassomiglino ad un ammasso di materiali, ad una discarica di scarti in cui l’uomo non è scarto da meno, e nei quali tuttavia vige un’estetica se non del brutto certo di un certo horror pleni che ci sovrasta. Voglio dire che è inevitabile (nel senso di un rapporto efficiente tra forma e contenuto) che questi testi siano tra le altre cose, quando funzionano al meglio, una sorta di “lista profetica dei significati”, per citare l’autore. Nella quale cioè non vale tanto la parola in sé, quanto la massa critica della sua evocazione complessiva, non il suo valore storico ma quello dinamico-predittivo, proprio in forza di alcuni di quegli accostamenti alieni di cui parlavo nei quali gli enunciati si danno energia a vicenda. Vale lo stesso, per forza di cose, se il tema è l’uomo scarto, l’uomo ambiente, l’uomo perdente all’interno di un ecosistema suicidario perché autoinflitto, non solo come abitante di una terra devastata ma anche come attore di rapporti spesso difficili (dove magari “l’altruismo è una sorta di narcisismo imperterrito, non illuderti”) o affetto da una “mancanza di comunitività” (così nel testo) o per il quale l’avvenire è una “stupida crisalide” cioè forse non destinato a compiersi per l’uomo che vive in un mondo che urla. Se da un certo punto di vista il gioco dell’autore è scoperto, se la sua fame nervosa di comprendere il tutto è evidente, è vero che alla fine la pressione dei significati e dell’ evocazione espressa è importante e bisogna tenerne conto al di là di piccoli o grandi dejà vu e di una qualche ricorsività indotta da uno stile, una tonalità, una voce che tende sempre e comunque a replicarsi, perché evidentemente l’autore ne è soddisfatto. Non occorre dire che cosa passa tra soddisfazione e sperimentazione, a lungo andare. Ma il libro è di sicuro interesse, con diversi testi anche molto belli, e sono curioso di vedere i futuri lavori di Piccione. (g. cerrai)