Iacopo Ninni – Animalie (con illustrazioni di Marta Carraro) – Seri Editore 2023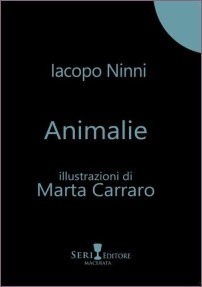
Tra la metafora e il simbolo, tra il serio e il faceto, tra la realtà e il fantastico è questo libro di Iacopo Ninni in cui, come pure nelle belle illustrazioni che lo corredano, l’uomo e l’animale si confrontano e non poche volte si confondono, riconoscendosi una somiglianza, una comunanza, un destino spesso in mano all’arbitrio di altri. Tutto in questi versi è leggero, eppure non lo è, anche là dove l’ironia o il calembour sono ben presenti come cifra dominante, anche dove – certo – il gioco di parole sembra più scontato o addirittura superfluo. In fondo, come in certi epigrammi, c’è sempre una nota amara, sia essa per l’uomo o per l’animale, e se non proprio una morale almeno un pensiero, una piccola riflessione che sfugga per un momento al rumor bianco della contemporaneità.
Ninni in effetti sceglie un campo metaforico relativamente semplice e tuttavia antico quanto la letteratura, almeno dal tempo di Esopo, senza mai dimenticarsi, nel tono dominante, di divertirsi. Ne esce spesso un andamento favolistico, fragile come tutte le favole se dovessimo metterle alla prova del totalmente disilluso mondo attuale (ma qui basta, come ho detto prima, rallentare, prendersi il giusto tempo); altre volte l’attributo animale (come un ronzio) diventa immediatamente un connotato umano, se mai ci fosse bisogno di una riprova che in fondo di umani si parla, come una comunicazione traslata o traslitterata tra di loro, come ad es. qui sotto Effigie lupi, pardorum maculis (proprio perché metafore, qui gli animali non sono certo un tema di tipo ideologico, come per intenderci in Laura Liberale); altre volte ancora l’animale non viene nemmeno nominato, non è necessario, l’oggettività non serve quando il tono lirico-elegiaco parla sentimentalmente del destino di tutti, uomini e animali (v. sotto Lettera da Calidone). In breve, Ninni realizza qui un piccolo bestiario, con l’intento forse di farne un’operetta morale, scegliendo una efficace scrittura tersa e breve, che come già detto tende quasi sempre ad una soluzione finale, che coagula o conclude il significato complessivo, come una musichetta che si ricongiunga in chiusura con la sua tonica. (g. cerrai)

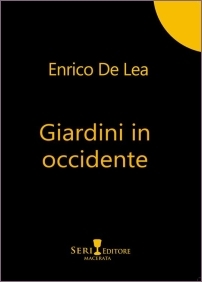 Enrico De Lea – Giardini in occidente – Seri Editore, 2022
Enrico De Lea – Giardini in occidente – Seri Editore, 2022