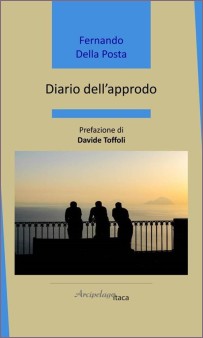 Fernando Della Posta – Diario dell’approdo – Arcipelago Itaca, 2024
Fernando Della Posta – Diario dell’approdo – Arcipelago Itaca, 2024
.
Fernando Della Posta indica la Luna e guarda la terra, o almeno il suolo che calca. Intitola le sezioni del suo libro con toponimi di regioni lunari e sembra che voglia proporsi come un Astolfo alla ricerca di un senso che – oggi – ci appare sfuggente, oppure di un senno che però non è detto sia possibile trovare altrove da qui, da questa complicata realtà. Hic manebimus, volenti o nolenti, il resto è aspirazione. Teniamo presente questo, per intanto, e teniamo presente però anche chi avvertiva della difficoltà di trovare risposte se le domande non siano ben formulate. Una tra le tante: “dove andiamo?”. Si tratta qui di un percorso o di piccoli tragitti o frammenti di essi in cui però – scrive Fernando – “l’approdo è tutti i giorni”, cosa che equivale a dire, con Ungaretti, che “qui la meta è partire”, cioè coltivare, magari per sempre, il desiderio e il bisogno di quell’altrove, che poi si sostanzia, alla fine, in un ritorno a casa, un nostos. Il primo passo, per Fernando e molti altri suoi coetanei, è misurare una metaforica stanza e il suo perimetro, un luogo in fondo concluso che può essere ovunque, perché se la realtà è complicata e confusa lo è, nel mondo e nella mente, in egual misura a New York come a Roma o a Pontecorvo (FR). Tanto che la dedica è riservata “a tutti i fuori spazio e i fuori tempo”, a cui forse bisogna aggiungere i “fuori luogo”. E tuttavia da quel luogo, fisico o dell’anima, non si può scappare, è anche in fondo una questione di identità. È vero che c’è sempre una partenza, avviene ogni giorno, ogni mattina nel decidere se scendere dal letto, come ci dice il testo di apertura, e dell’approdo si è già detto. Così questo libro potrebbe essere, forse non volendo, un voyage autour de sa chambre, proprio nel senso che si è detto. L’orizzonte, con i suoi limiti, è quello, anche quando si parla di una città o di un’isola, di una data o di una via, cioè di qualcosa che potrebbe essere oggettivamente preciso. Tanto che “sempre si approda / alla posizione periferica”, ovvero in un luogo (fisico o dell’anima, ripeto) ristretto, o in cui comunque ci si sente spettatori, defilati e neanche tanto influenti. Si tratta, per metonimia, della condizione umana, di un canto dell’uomo errante dell’Occidente? Certamente di questo, e allora la risposta alla domanda “dove andiamo?” potrebbe essere “in nessun posto”, stante che in questo mondo non c’è più niente da scoprire; ma potrebbe trattarsi anche della necessità di reperire, autour de la chambre, le “cose”, i segni tangibili di un posto in cui realmente siamo esistiti. Ricordi e suggestioni e singolarità, ma anche metafore “concrete” (o convinzioni un po’ aforistiche e assertive, o ovvie, e perfino tratteggi al limite del bozzetto), sono “cose” come bitte a cui legare le cime all’approdo. Nei mari lunari allora Fernando, adottando un approccio linguisticamente ellittico (e per lo più lirico) cerca reperti per trarne conclusioni di cui per ossimoro non v’è certezza, ma che hanno il confortante pregio o di rompere la superficie, “la divisione surreale dello stagno”, di spingersi “fino al reale” (obbiettivo però ben più ambizioso della realtà, cosa diversa); oppure, nel momento in cui quel reale si creda di afferrare, di illuderci che quella scheggia abbia un senso (per il poeta, in quanto titolare di uno sguardo “speciale”, e insieme per l’uomo comune: Ogni uomo è prima di tutto il poeta, / il poeta che ci muore tra le braccia, / dopo che c’è salito in grembo, non visto). Che nella poesia di Della Posta ci sia questo intento per così dire universalistico lo indica, tra altre cose, l’uso frequente di un soggetto plurale (noi, ci ecc..) che non è il consueto mascheramento dell’io poetico, ma che cerca appunto di disegnare una communitas umana, esistenziale, fornendo quasi un indirizzo filosofico, un’idea di mondo. Non sempre ci riesce, perché quando affiora una sorta di “convinzione” autoriale che asserisce una visione personale delle cose, il risultato appare per converso meno convincente, più predittivo. Tanto che, a mio avviso, le cose migliori sono forse quelle meno “pensate” e pensose. E poco importa, dal punto di vista di diatribe che lasciano il tempo che trovano, se ne traspare un certo lirismo, in cui però la scrittura di Fernando, sempre di rilievo, riesce a dare il meglio di sé. Siamo in ogni caso in un alveo ben delimitato, in cui si ritrovano echi montaliani, perfino petrarcheschi, in cui la buona scrittura spesso è più significativa di ciò che vuole rappresentare, più precisa di quanto vuole descrivere, il terreno cioè di una ormai tradizionale cura della parola come cura di una visione viceversa incerta, a volte simbolistica, del mondo. (g. cerrai)
. Continua a leggere→
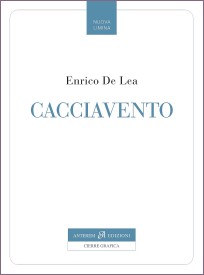

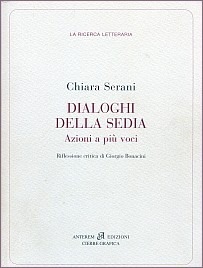 Note a margine: Chiara Serani ovvero Dā mihi sellulam, ubi cōnsistam
Note a margine: Chiara Serani ovvero Dā mihi sellulam, ubi cōnsistam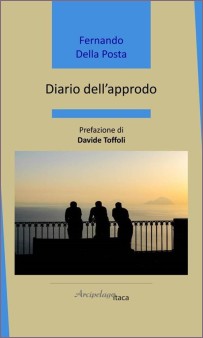 Fernando Della Posta – Diario dell’approdo –
Fernando Della Posta – Diario dell’approdo – 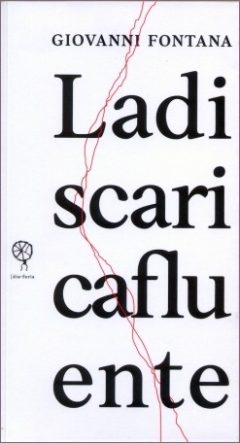
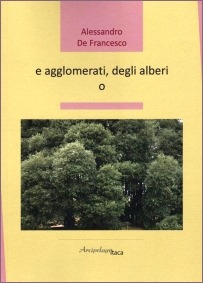 Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!
Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!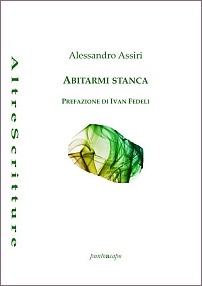 Alessandro Assiri – Abitarmi stanca –
Alessandro Assiri – Abitarmi stanca – 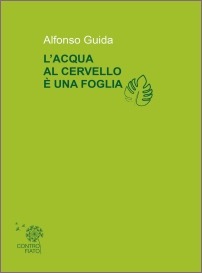 Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia –
Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia – 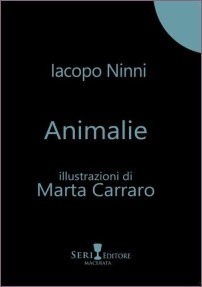
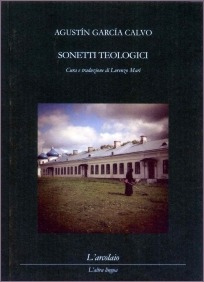 Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019
Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019 Paolo Artale – Conversazioni in giardino – Contatti Edizioni, collana BLU 77, 2022
Paolo Artale – Conversazioni in giardino – Contatti Edizioni, collana BLU 77, 2022