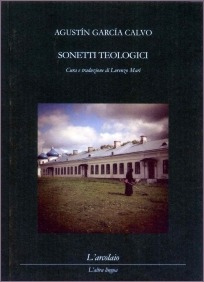 Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019
Agustín García Calvo – Sonetti teologici – L’Arcolaio, 2019
Un libro non si perde mai del tutto. Neanche ciò che vi è contenuto. Si ritrova il libro, si capisce il senso di certe cose. Un buon mezzo per ritrovare un libro è cercare di mettere ordine in quelli che hai sparsi per casa. Un libro che ti è stato inviato in saggio, magari, forse con una dedica amichevole o affettuosa. Così ieri ho ritrovato un libretto tanto smilzo quanto denso, che risale al 2019, “per Giacomo, con la stima di sempre”. La firma è racchiusa tra due “signos de interrogación”, due punti interrogativi come fanno gli spagnoli, ed è quella di Lorenzo Mari. Non credo di avere fatto caso all’epoca, pur avendo letto il libro, a quella domanda esplicita. In spagnolo ci sono quei due segni che racchiudono una frase interrogativa perché gli spagnoli non amano che ci siano dubbi sul fatto che si tratta proprio di una domanda(non è del tutto vero, ma mi piace pensarlo).
Il libro in questione è “Sonetti teologici” di Agustìn Garcìa Calvo. Calvo è stato un importante filosofo, poeta, traduttore e filologo spagnolo, oppositore della dittatura franchista, “maestro” di Fernando Savater, filosofo noto anche da noi; Mari è poeta, traduttore (ottimo) e curatore di questo libro, nonché una vecchia conoscenza di questo blog (v. QUI). Leggo che era proprio abitudine di Calvo firmarsi con i “signos de interrogatión”. Ecco spiegato l’autografo di Mari, un ammiccamento che mi dispiace di aver colto solo dopo tanto tempo.
I sonetti in realtà sono solo due, ma preziosi e esaurienti, alla luce della visione filosofica di Calvo che sia Mari nella prefazione sia lo stesso Calvo in una intervista riportata nel volumetto esprimono chiaramente (entrambi gli scritti, va detto, sono assai illuminanti e fanno da degno castone ai due sonetti, anzi già da soli valgono l’acquisto dell’opera). Continua a leggere

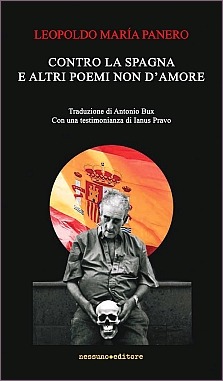 Leopoldo Maria Panero – Contro la Spagna e altri poemi non d’amore – Nessuno editore, 2020 – trad. di
Leopoldo Maria Panero – Contro la Spagna e altri poemi non d’amore – Nessuno editore, 2020 – trad. di 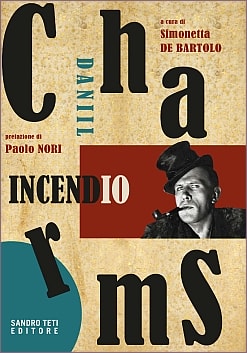 Daniil Charms – Incendio – a cura di Simonetta De Bartolo, prefazione di Paolo Nori, introduzione di Valerij Sažin –
Daniil Charms – Incendio – a cura di Simonetta De Bartolo, prefazione di Paolo Nori, introduzione di Valerij Sažin – 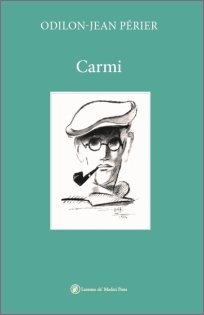 Odilon-Jean Périer – Carmi, a cura di Ilaria Guidantoni,
Odilon-Jean Périer – Carmi, a cura di Ilaria Guidantoni,  Baudelaire e Les fleurs du mal: un legame inscindibile
Baudelaire e Les fleurs du mal: un legame inscindibile Uno dei miei antidoti preferiti all’uggia che mi provoca la lettura di certi versi a cui a volte sono costretto è riprendere in mano qualche grande esponente di una poesia, specialmente del secolo scorso, che è di fatto classica, a cui non solo è possibile ma anche auspicabile fare riferimento. Come ad esempio W.C. Williams, qualche post fa, e come Hart Crane, un altro modernista autore di quel colosso poetico che è Il ponte (The bridge, in Italia tradotto da Roberto Sanesi per Guanda nel lontano 1967, poi ripreso da Garzanti mi pare negli anni Ottanta). Di lui il grande critico Harold Bloom diceva “scrive ogni testo in modo tale che tu senti letteralmente che morirà se non riesce a farcela, che la sua sopravvivenza non solo come poeta ma come persona dipende in qualche modo dall’articolazione di quella poesia”. Nel nostro paese credo siano ancora reperibili suoi libri usciti con le Edizioni Grenelle (tra cui questo White buildings) e con Mario Pagliai Editore (v. interessante anche
Uno dei miei antidoti preferiti all’uggia che mi provoca la lettura di certi versi a cui a volte sono costretto è riprendere in mano qualche grande esponente di una poesia, specialmente del secolo scorso, che è di fatto classica, a cui non solo è possibile ma anche auspicabile fare riferimento. Come ad esempio W.C. Williams, qualche post fa, e come Hart Crane, un altro modernista autore di quel colosso poetico che è Il ponte (The bridge, in Italia tradotto da Roberto Sanesi per Guanda nel lontano 1967, poi ripreso da Garzanti mi pare negli anni Ottanta). Di lui il grande critico Harold Bloom diceva “scrive ogni testo in modo tale che tu senti letteralmente che morirà se non riesce a farcela, che la sua sopravvivenza non solo come poeta ma come persona dipende in qualche modo dall’articolazione di quella poesia”. Nel nostro paese credo siano ancora reperibili suoi libri usciti con le Edizioni Grenelle (tra cui questo White buildings) e con Mario Pagliai Editore (v. interessante anche  Una piccola ma preziosa antologia bilingue, quella edita da Gradiva Publications di Luigi Fontanella, che collaziona testi editi di Luigi Cannillo, la parte più cospicua dei quali proviene da Galleria del vento, che ho recensito alla sua uscita e a cui rimando (v.
Una piccola ma preziosa antologia bilingue, quella edita da Gradiva Publications di Luigi Fontanella, che collaziona testi editi di Luigi Cannillo, la parte più cospicua dei quali proviene da Galleria del vento, che ho recensito alla sua uscita e a cui rimando (v.  È caldo, ancora. Ci sta quindi ripescare nel vasto archivio di Imperfetta Ellisse un mio post del 2017, una mia traduzione da Bataille, qualcosa che ha a che fare col sole (
È caldo, ancora. Ci sta quindi ripescare nel vasto archivio di Imperfetta Ellisse un mio post del 2017, una mia traduzione da Bataille, qualcosa che ha a che fare col sole ( Dall’archivio storico di Imperfetta Ellisse, un post del 2011 di sicuro interesse che vale la pena recuperare. Si parla di un autore tanto poco conosciuto quanto davvero impressionante.
Dall’archivio storico di Imperfetta Ellisse, un post del 2011 di sicuro interesse che vale la pena recuperare. Si parla di un autore tanto poco conosciuto quanto davvero impressionante.