
Tra qualche giorno saranno cinque anni dalla morte di Nanni Balestrini (19 maggio 2019). Mi anticipo un po’, non che ami particolarmente gli anniversari, solo perché riordinando mi è capitato tra le mani uno dei volumi delle Poesie complete pubblicate da Derive Approdi nel 2018 (precisamente il volume terzo / 1990-2017), Caosmogonia e altro, introduzione di Andrea Cortellessa più vari interventi critici in allegato. Inutile ricordare qui la persona di Balestrini e che cosa abbia rappresentato nel panorama letterario e culturale del nostro Paese, a partire dalla sua presenza fondante nella Neoavanguardia e come cofondatore e ideatore di storiche riviste letterarie come “Quindici” e “alfabeta”, ci sono centinaia di post, articoli, saggi utili allo scopo a cui rivolgersi.
Mi limito a riproporre un testo tratto dal libro citato, testo che unisce secondo lo stile del nostro ironia e pensiero, metodo critico e sberleffo, immediatezza e profondità, suono e significato, nonché vari livelli di linguaggio e, che non guasta, un po’ di sana ferocia. Si tratta di “La poesia fa malissimo”, una composizione inedita fino alla pubblicazione in questo volume, una sorta di invettiva che vuole ricordarci che la poesia è o dovrebbe essere “un affronto all’esistente per mezzo della parola”, una “interminabile apocalisse”. E quindi, perchè no, uno strumento politico.
Fa da contraltare all’ironica “La poesia fa benissimo”, del 2010, che lo segue nella sezione Intermezzo. La poesia fa male dello stesso volume (di cui forse parleremo un’altra volta) e nella quale molti poeti, lettori e frequentatori di reading certo si ritroveranno. Anche questa appartiene a un discreto gruppo di testi sparsi nei quali Balestrini si occupa tematicamente della poesia, della parola, del linguaggio, ci ricorda Cortellessa, come “movimento” da contrapporre alla sua stessa “inerzia”, come oggetto di scandalo (inteso nel suo etimo più radicale), come “opposizione” (“Linguaggio e opposizione” è il titolo di un suo noto intervento programmatico (v. QUI). Ricordando che Nanni Balestrini, più che un eversore della poesia e della lingua italiana “è in realtà un costruttore, un ingegnere o se si preferisce un architetto della poesia” (Fausto Curi). Buona lettura. (g.c.)

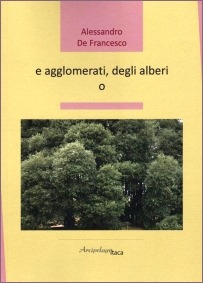 Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!
Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!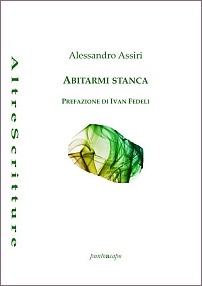 Alessandro Assiri – Abitarmi stanca –
Alessandro Assiri – Abitarmi stanca – 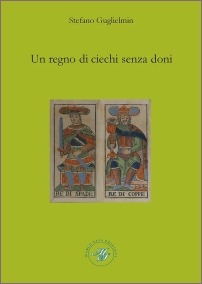 In attesa di parlarne domani con lui (Pisa,
In attesa di parlarne domani con lui (Pisa, 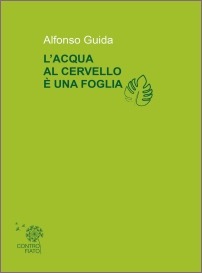 Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia –
Alfonso Guida – L’acqua al cervello è una foglia – 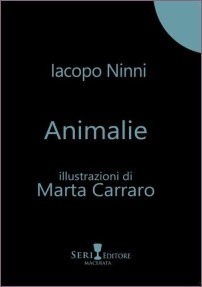
 Mario Lunetta – L’allenamento è finito
Mario Lunetta – L’allenamento è finito


 Poet’s cuisine – 01, Vittorio Sereni, La malattia dell’olmo
Poet’s cuisine – 01, Vittorio Sereni, La malattia dell’olmo