Alessandro De Francesco – e agglomerati, degli alberi o – Arcipelago Itaca, 2023
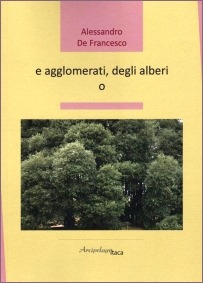 Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman![1]“), giacché mettere in discussione il definibile fa parte del loro gioco. Parlare di oggetti poetici non è un vezzo ma una precisa intenzione. Specie nel caso di questo libro di Alessandro De Francesco, che è un libro, su questo non ci sono dubbi, ma forse non è alcune altre cose e altre cose vuole diventare. Non è una desueta raccolta, non è una silloge, non è (ma forse forse) un prosimetro, non è, non mi sembra, una installazione, e volerlo relegare nell’ambito della scrittura di ricerca o sperimentale sarebbe tanto generico quanto lapalissiano (oltre ad essere, dice l’autore, “un formalismo fuori tempo massimo”). Certamente è un oggetto che sembra soffrire di dover essere stampato su carta, di diventare statico, non interattivo, non ulteriormente deformabile (come vedremo). È proprio con questa materialità “definitiva” che ho avuto il primo approccio quando ho pensato di farne una piccola recensione, ricevendone di che riflettere. È vero che tutti i libri sono materiali e concreti, ma è anche vero che questo in particolare tende a rappresentare, di questa materialità, una vis insieme centrifuga e ineffabile, come un “prigione” di Michelangelo.
Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman![1]“), giacché mettere in discussione il definibile fa parte del loro gioco. Parlare di oggetti poetici non è un vezzo ma una precisa intenzione. Specie nel caso di questo libro di Alessandro De Francesco, che è un libro, su questo non ci sono dubbi, ma forse non è alcune altre cose e altre cose vuole diventare. Non è una desueta raccolta, non è una silloge, non è (ma forse forse) un prosimetro, non è, non mi sembra, una installazione, e volerlo relegare nell’ambito della scrittura di ricerca o sperimentale sarebbe tanto generico quanto lapalissiano (oltre ad essere, dice l’autore, “un formalismo fuori tempo massimo”). Certamente è un oggetto che sembra soffrire di dover essere stampato su carta, di diventare statico, non interattivo, non ulteriormente deformabile (come vedremo). È proprio con questa materialità “definitiva” che ho avuto il primo approccio quando ho pensato di farne una piccola recensione, ricevendone di che riflettere. È vero che tutti i libri sono materiali e concreti, ma è anche vero che questo in particolare tende a rappresentare, di questa materialità, una vis insieme centrifuga e ineffabile, come un “prigione” di Michelangelo.
Per consuetudine di questo blog quando scrivo una nota su di un libro aggiungo anche, ad usum lectoris, qualche testo esemplificativo. Col cartaceo si lavora di scanner e OCR, con i pdf si fa una semplice estrazione dei brani che interessano, tutto lì. Ma il lavoro di De Francesco è un particolare assemblaggio di testi tipografici “originali” (che si presume abbiano avuto una stesura, digitale o analogica, precedente alla stampa) e frammenti, estratti, specimen di opere (libri, siti, documenti) diverse ed aliene. I primi corrispondono ad un testo in varia misura “leggibile”, di cui cioè trasmettono un senso interpretabile mediante una qualche verbalizzazione (ma non necessariamente parafrasi), ancorché sia esso sottoposto talvolta a torsioni, sovrascritture, rovesciamenti speculari, cancellazioni, abrasioni o “danneggiamenti” di qualche tipo (v. esempi più avanti); i secondi sono “citazioni” (presenti peraltro anche nei primi) o copie, per lo più di dati, elenchi, nomenclature o – appunto – agglomerati. Sono questi ultimi, come vedremo, ad aver subíto la maggiore de-formazione, almeno finché andando in stampa sono sfuggiti alla ulteriore “violenza” dell’autore (ma va detto che quella dinamica, come suggestione di un moto inerziale, è destinata a perdurare). Continua a leggere

 Unità stratigrafiche di Laura Liberale – Nota critica di Claudia Mirrione
Unità stratigrafiche di Laura Liberale – Nota critica di Claudia Mirrione Il paese invisibile e il passo per inventarlo di Roberto Marcòni: un percorso attraverso la paesologia dello spirito
Il paese invisibile e il passo per inventarlo di Roberto Marcòni: un percorso attraverso la paesologia dello spirito Silvia Patrizio – Smentire il bianco –
Silvia Patrizio – Smentire il bianco – 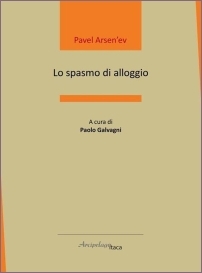
 Anamorfiche di Danilo Mandolini
Anamorfiche di Danilo Mandolini

 Francesco Lorusso – Maceria – Arcipelago Itaca, 2020
Francesco Lorusso – Maceria – Arcipelago Itaca, 2020