 L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di Augusto Blotto ([dia*foria / dreamBOOK, ISBN 9788899830519, pagg. 260, con interventi di Giacomo Cerrai, Philippe Di Meo, Chiara Serani, Stefano Agosti) tenta con la speranza di qualche successo non solo di ampliare la conoscenza di questo grande vecchio (Torino, 1933) della poesia italiana, ma anche di riaccendere l’attenzione su di un autore forse appartato ma certo non più adeguatamente analizzato, con rare eccezioni, dopo la giornata di studi a lui dedicata a Torino il 27 novembre 2009 (ora in Il clamoroso non incominciar neppure – Atti della giornata di studio in onore di Augusto Blotto (Ed. dell’Orso, 2010, con quattordici saggi di vari importanti autori).
L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di Augusto Blotto ([dia*foria / dreamBOOK, ISBN 9788899830519, pagg. 260, con interventi di Giacomo Cerrai, Philippe Di Meo, Chiara Serani, Stefano Agosti) tenta con la speranza di qualche successo non solo di ampliare la conoscenza di questo grande vecchio (Torino, 1933) della poesia italiana, ma anche di riaccendere l’attenzione su di un autore forse appartato ma certo non più adeguatamente analizzato, con rare eccezioni, dopo la giornata di studi a lui dedicata a Torino il 27 novembre 2009 (ora in Il clamoroso non incominciar neppure – Atti della giornata di studio in onore di Augusto Blotto (Ed. dell’Orso, 2010, con quattordici saggi di vari importanti autori).
Incominciamo col dire che questo volume non è una delle opere di Augusto Blotto, per il quale non vige affatto né il concetto di compiutezza “finita” né quello di un determinarsi conseguente e successivo del lavoro poetico né, forse, nemmeno quello ancora di tempo lineare, sebbene ogni suo libro abbia poi una sua precisa identità, una “aura che vi circola” come dice lui. È semmai una delle “emergenze”, degli affioramenti dell’inesausto lavorio blottiano. Blotto infatti è autore di un lavoro sterminato (circa ventisei opere a stampa e materiale per ipotetici almeno altri ventinove volumi), e anche questo libro è una sorta di carotaggio, una ricognizione campionaria per “estrazioni dai giacimenti” di quella che possiamo chiamare d’ora in avanti l’Opera, ovvero “l’enfin”, attualmente composto da oltre 2700 cartelle. Blotto, come scrisse uno dei suoi estimatori Giovanni Tesio, è un poeta “di sfide e dismisure”, un ricercatore indefesso che scava nel corpo immenso del linguaggio e della realtà che esso rappresenta, ne rivoluziona la sintassi, rivede senza patemi gli schemi metaforici, gli accostamenti di senso, le immagini che ne derivano, insomma un osservatore acribico del mondo che egli, grande camminatore, percorre come uno specialissimo flâneur ricevendone stimoli fluviali che l’autore organizza ed ha organizzato nel corso del suo lavoro in quello che Daniele Poletti nell’introduzione definisce un mastodontico iperoggetto letterario, uno spazio vasto che ricomprende tutti i paesaggi in cui Blotto ha fatto irruzione ridefinendoli in una nuova matrice. Ed è il linguaggio una delle maggiori peculiarità della sua poesia, una lingua non meramente strumentale né mimetica del caos del mondo, della sua incomprensibilità, ma intesa – tra le altre cose – come manifestazione del tempo (letterario ed esistenziale) quale “visione sincronica ed onnivora della realtà”, ove “il tempo è momento, o un luogo quasi topologico in cui precipitano le cose, gli oggetti, gli “accidenti” – nonché il linguaggio che li determina – e che ha una durata pari a quella del testo che li contiene, ma che non ha altra rappresentazione per così dire “lineare” o analogica, non fluisce, non ha nemmeno la figurazione di un prima e di un dopo attraverso la sintassi, la cui mobilità è segnale semmai che la realtà “avvenuta” è soggetta a una continua (finché il testo lo consente) revisione testimoniale”. Ma “il linguaggio sembra avere per Blotto un peccato originale, una tabe, variamente connotata, in primis dalla rigidità del codice, con il quale tuttavia, in quanto materia, dobbiamo avere a che fare (non dimenticando che il linguaggio nella sua essenza è sempre “narrativo”, sequenziale, ordinatorio, e vive nel tempo che il testo si è dato, come abbiamo detto). E poi connotata da un comfort associativo, con cui la mente giunge a conclusioni “economiche”, in qualche caso anticipatorie, “usabili” e quindi in varia misura scontate”. È l’ “ordine costituito del linguaggio” che viene da Blotto rivoluzionato, anche spessissimo sotto il profilo sintattico, cose che non impediscono però a Blotto di attingere vette anche liriche, anche umoristiche e sempre di altissimo valore descrittivo e iconico. Perché “l’atteggiamento di Blotto non è puramente contestatorio: la distruzione (la messa in crisi) dei meccanismi è in realtà la ricostruzione delle loro macerie sotto altra forma, con altri mezzi, è la proposta (peraltro un po’ imperiosa) di non lasciarsi intimorire dal sublime, nel senso di gettare uno sguardo su di una vastità impressionante, che riguarda, come un Caspar David Friedrich delle parole, quella delle possibilità del linguaggio”. Blotto è poeta ricchissimo, non solo della cultura che dimostra e trasfonde nei suoi versi, ma anche di una infinità di dati informativi, sensoriali, eidetici, linguistici, oggettuali e ideativi che fornisce al lettore. Il quale, se può essere soggetto ad un “sentimento di instabilità, di non comfort (concetto tutt’altro che peregrino, basti pensare al barthesiano “piacere del testo”)”, è perché viene “condizionato” anche cognitivamente. “Condizionamento” (usiamo ancora le virgolette) che, nel suo caso, “non riguarda soltanto l’espressione di una sua realtà, ma anche come questa realtà debba essere riformulata, tramite il linguaggio, nel pensiero, anche di chi legge”. Non è una semplice seduzione, è la più alta corresponsabilità del lettore. Una esperienza che possiamo definire assoluta. (g.cerrai) Continua a leggere→


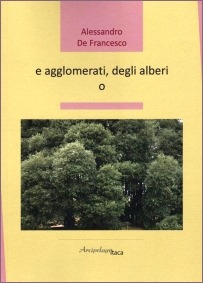 Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman!
Ci sono oggetti poetici di non facile manipolazione, almeno al fine di una nota, di una recensione, o solo quando si voglia citarne degli esempi. Ci sono oggetti poetici complessi, di non facile definizione, alla quale – forse – semplicemente vogliono sfuggire (“È un aereo? È un uccello? No, è Superman! Mario Lunetta – L’allenamento è finito
Mario Lunetta – L’allenamento è finito Un testo di Mario Diacono, tratto dal prezioso libro Mario Diacono – THE OCCULTA POESIA, tre libri, pubblicato nel 2021, da
Un testo di Mario Diacono, tratto dal prezioso libro Mario Diacono – THE OCCULTA POESIA, tre libri, pubblicato nel 2021, da  L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di
L’uscita, avvenuta nell’aprile 2021, di Ragioni, a piene mani, per l’ “enfin!” di  Laura Liberale – Unità stratigrafiche – Arcipelago Itaca 2020
Laura Liberale – Unità stratigrafiche – Arcipelago Itaca 2020


 Ho sentito
Ho sentito