 Bologna in Lettere 2023 – Segnalati sez. C: Stefano Baldinu
Bologna in Lettere 2023 – Segnalati sez. C: Stefano Baldinu
Come giuria della sezione C (poesie inedite) di Bologna in Lettere 2023 abbiamo anche il compito di stendere le motivazioni dei premi (o delle segnalazioni, come in questo caso). Pubblico anche qui, insieme ai testi, quelle di cui sono autore. – 2 Stefano Baldinu.
Una voce intensamente lirica, quella di Stefano Baldinu, ma di un lirismo per così dire conservativo, come la lingua che usa, il logudorese, una delle espressioni più significative e letterarie della lingua sarda, aspro e insieme musicale, con le sue contaminazioni castigliane. Dire conservativo non comporta nessuna sfumatura di demerito, significa piuttosto dare credito a Baldinu di una sensibilità in via di estinzione, nutrita di attenzione per le cose e le persone, per i momenti e le storie anche semplici di una umanità apparentemente minore e tuttavia emblematica, che nei versi di Baldinu tende ad assumere delle sembianze angeliche, ad essere portatrice di una ingenuità quasi fanciullesca e perciò pura. Personaggi come Marcu o Miali (Michele) sono i “semplici” o forse i folli che in un cortile o in una domenica di periferia, con i loro semplici gesti si avvicinano a qualcosa, intravedono come Giacobbe qualcosa di mistico, diventano proiezioni appunto angeliche dell’autore che, in quello stesso cortile e come loro, cerca una presenza nelle cose o tra “le pagine inesistenti di un sussidiario di felicità”, un contatto “cun sos poddighes de Deu”, con i polpastrelli di Dio (ed ecco una bella suggestione michelangiolesca).
Linguaggio e tema in Baldinu sono quanto mai aderenti, pur apparendo in qualche modo antagonisti: l’uno è ricco e articolato, capace di costruire in lunghe ipotassi immagini e analogie efficaci, l’altro trova in questo tipo di costruzione l’agio e il fiato per sviluppare la sua doppia semplicità, quella di “fatto” in sé e quello di “idea” poetica e sentimentale che il fatto incarna e giustifica. Idea (e convinzione direi) di una spiritualità come valore poetico assoluto, come manifestazione quasi epifanica ma quotidiana di una costante nella sua vita. Nella terna presentata Baldinu nomina il nome di Dio tre volte ma non invano: c’è, è una presenza quasi consueta e “naturale”, è familiare non meno di Marcu o Miali (o Stefano) che nei cortili stanno lì “a abbaidare s’ortografia impretzisa de s’immensu”, ad osservare l’ortografia inesatta dell’immenso. (g. cerrai)

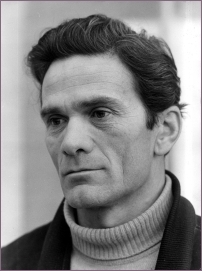

 Alcune poesie tratte da 44 ottave, libro con cui Emilio Rentocchini ha raggiunto il traguardo (a suo dire invalicabile) dei 300 testi in questa forma chiusa e con questo suo dialetto sassuolese, con a fronte la versione italiana (le altre 256, sparse in diversi libri negli anni a partire dal 1994, sono ora raccolte in Lingua madre – Incontri, 2016).
Alcune poesie tratte da 44 ottave, libro con cui Emilio Rentocchini ha raggiunto il traguardo (a suo dire invalicabile) dei 300 testi in questa forma chiusa e con questo suo dialetto sassuolese, con a fronte la versione italiana (le altre 256, sparse in diversi libri negli anni a partire dal 1994, sono ora raccolte in Lingua madre – Incontri, 2016).